
La “lettura” dell’ambiente meridionale da parte di un numero crescente di scrittori ha avuto un indubbio incremento dopo l’Unità d’Italia. Il raffronto con le condizioni socio-economiche del Nord ha stimolato molti autori a denunciare l’arretratezza del nostro Mezzogiorno, una situazione frutto di squilibri sociali, disparità economiche, ingiustizie sociali e fenomeni di prevaricazione, sopruso, ricatto. Tra gli autori è comune il sentimento di amarezza, sfiducia e frustrazione di fronte a territori segnati dall’analfabetismo, dalla sopravvivenza, da un’economia agraria basata sul latifondo e sullo sfruttamento, dalla mancanza di un ceto borghese evoluto e, a seguire, dal flagello dell’emigrazione. Molti romanzi certificano un fallimento esteso, individuale e collettivo, economico e culturale.
“C’è fra il nord e il sud della penisola una grande sproporzione nel campo delle attività umane, nella intensità della vita collettiva, nella misura e nel genere della produzione, e, quindi, per gli intimi legami che corrono tra il benessere e l’anima di un popolo, anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale – scriveva il lucano Giustino Fortunato, tra i più importanti meridionalisti.

È diffuso, in particolare, tra gli autori, l’antagonismo tra l’analisi oggettiva della società e la storia del sud: un contrasto segnato dallo sconforto per ataviche dominazioni su più livelli – da quello familiare a quello amministrativo – e dall’incapacità del riscatto. Non c’è traccia di evoluzione e di modernità, semmai si perpetuano riti di conservazione: è palese che i processi risorgimentali e unitari non abbiano apportato miglioramenti, sembrano fasi incomplete o tradite dove le flebili spinte all’innovazione sono accompagnate da un’atavica diffidenza.
Bene scrive Giuseppe Lupo: “Dal narrare angioino, il Sud è approdato al narrare aragonese, dal racconto di fantasia al racconto di fatti nudi e crudi. Questa operazione di capovolgimento trova legittimazione in Giovanni Verga, il grande tronco da cui prende vita la narrativa meridionale nella contemporaneità e che in termini non soltanto simbolici significa l’egemonia della scrittura notarile sulla scrittura visionaria, la vittoria dello scriba sul profeta”.
Eccola, allora, la “questione meridionale” – definizione usata per la prima volta nel 1873 dal deputato lombardo Antonio Billia – che calamita anche la letteratura. Ecco quei territori definiti “sfasciume pendulo” dal meridionalista Giustino Fortunato a causa delle infrastrutture totalmente inadeguate, dalle strade alle ferrovie, dagli acquedotti alle scuole fino ai servizi pubblici da quarto mondo.

La grande letteratura meridionale, nata con il siciliano Giovanni Verga, continua a produrre autori ancora oggi. Innumerevoli i capolavori che toccano tutte le regioni del Sud: dal “Ventre di Napoli” (1884) della napoletana Matilde Serao ai “Viceré” (1894) del concittadino Federigo De Roberto, da “Canne al vento” (1913) della sarda Grazia Deledda alle geniali opere del siciliano Luigi Pirandello o dei napoletani Eduardo e Peppino De Filippo, da “Gente in Aspromonte” (1930) del calabrese Corrado Alvaro a “Fontamara” (1933) dell’abruzzese Ignazio Silone, da “Cristo si è fermato ad Eboli” (1944) del torinese Carlo Levi a “Tiro al piccione” (1945) del molisano Giose Rimanelli oal “Gattopardo” (1958) del siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Poi le opere del molisano Francesco Jovine (1902-1950), del laziale-campano Tommaso Landolfi (1908-1979), dei napoletani Carlo Bernari (1909-1992), Domenico Rea (1921-1994) e Raffaele La Capria (1922), dei campani Alfonso Gatto (1909-1976) e Michele Prisco (1920-2003), dei lucani Vincenzo Buccino (1920-2005) e Rocco Scotellaro (1923-1953), dell’abruzzese Mario Pomilio (1921-1990), dei siciliani Salvatore Quasimodo (1901-1968), Elio Vittorini (1908-1966), Gesualdo Bufalino (1920-1996), Leonardo Sciascia (1921-1989) e Andrea Camilleri (1925-2019).
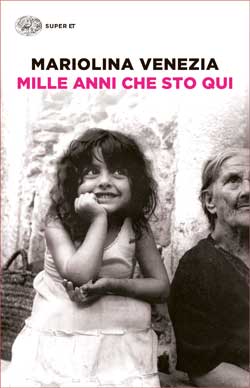
della materana Mariolina Venezia
La propensione alla scrittura non ha abbandonato, di certo, il Sud Italia. Ancora oggi, nel panorama della letteratura italiana contemporanea, gli scrittori meridionali costituiscono il gruppo più numeroso e raggiungono i vertici delle classifiche dei libri più venduti, spesso firmando opere che sono diventate dei classici. L’elenco è particolarmente lungo, per cui ci limitiamo a qualche nome.
Si pensi ai napoletani Erri De Luca, Elena Ferrante, Giuseppe Montesano, Antonio Pascale, Roberto Saviano, Marzia Sicignano e Domenico Starnone o al casertano Francesco Piccolo. Particolarmente nutrita la presenza siciliana: Simonetta Agnello Horby, Stefania Auci, Alessandro D’Avenia, Alessia Gazzola, Giuseppina Torregrossa. Ancora: i pugliesi Donato Carrisi e Gianrico Carofiglio, la lucana Mariolina Venezia, il calabrese Carmine Abate, la sarda Michela Murgia. Scrittori che tengono viva la tradizione di “raccontare il Mezzogiorno”, forse perché la realtà meridionale è quanto mai rappresentativa, specie oggi, a dell’intero Paese.
Si ringrazia Marco Calvo, fondatore di Liber Liber, per la concessione dei libri liberi da diritto d’autore.
LIBRI (SCARICABILI) DI AUTORI MERIDIONALI
–
ABRUZZO
Serafino de’ Ciminelli (Aquilano) – Opere
Daniele Oberto Marrama – Novelle e poesie
–
MOLISE
Francesco Jovine – L’impero in provincia
Francesco Jovine – Terre del Sacramento
–
CAMPANIA
Torquato Accetto – Della dissimulazione onesta
Domenico Basile – Il pastor fido
Roberto Bracco – Sperduti nel buio
Piero Cantalupo – De flore dietarum (trattatello medioevale salernitano sull’alimentazione)
Matteo Cuomo – Nel mondo dei libri
Guido De Ruggiero – Filosofi del Novecento
Francesco de Sanctis – Storia della letteratura italiana
Carlo Formichi – Apologia del buddismo
Alfredo Gargiulo – Tempo di ricordi
Angelo Gatti – Ilia ed Alberto (romanzo)
Antonio Labriola – Da un secolo all’altro
Giovanni Lanzalone – Verso il linguaggio universale
Francesco Mastriani – Il mio cadavere
Carlo Pascal – Per la resurrezione del latino
Carlo Pisacane – La rivoluzione
Maria Savi Lopez – Tramonto regale
Eduardo Scarpetta – Miseria e nobiltà
Maria Scarpetta – Felice Sciosciammocca mio padre
Nicola Valletta – Il celebre trattato della jettatura
Federigo Verdinois – Nuove novelle
Raffaele Viviani – Dalla vita alle scene
–
PUGLIA
Giacomo Bellacchi – Galileo e i suoi successori
Luigi Blanch – Della scienza militare
Carlo Cafiero – Rivoluzione per la rivoluzione
Luigi Chiarelli – L’anello di Teodosio
Umberto Fraccacreta – Amore e terra
Giuseppe Gabrieli – Dante e l’Oriente
Achille Pellizzari – Memorie antiche
Carlo Veneziani – Vent’anni di beffe
–
BASILICATA
Ferdinando Petruccelli della Gattina – Le Grandi Etere
–
CALABRIA
Antonino Anile – Vigilie di scienza e di vita
Oreste Dito – Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano
Bruno Misefari – Diario di un disertore
Domenico Nucera Abenavoli – L’emigrazione sconosciuta
Francesco Saverio Salfi – Il general Colli in Roma
Luigi Siciliani – Canti pagani
–
SICILIA
Emilio Bufardeci – Le funeste conseguenze di un pregiudizio popolare
Salvatore Cannizzaro – Sunto di un corso di filosofia chimica
Mariannina Coffa Caruso – Nuovi canti
Gaetano M. Columba – Storia e metodo storico
Federico De Roberto – I Vicerè
Filippo Eredia – Il fuoco e la luce
Luigi Grande – Diritto all’ozio
Giovanni Filippo Ingrassia – Informatione del pestifero morbo
Nino Martoglio – San Giovanni Decollato
Giovanni Meli – L’origini de lu munnu
Filippo Parlatore – Sulla respirazione delle piante
Calogero Angelo Sacheli – Atto e valore
Saverio Scrofani – Viaggio in Grecia
Giuseppe Sergi – Animismo e spiritismo
Giuseppe Varvaro – Anime deboli

